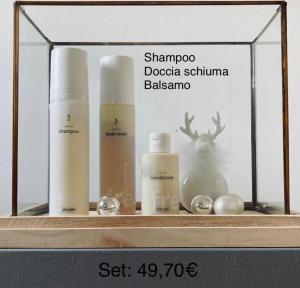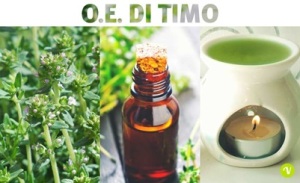NOME BOTANICO: Hypericum perforatum
NOMI VOLGARI
Cacciadiavoli, Erba di S. Giovanni, Millebuchi, Perforata, Erba trona, Erba dell’olio rosso, Cingulus Sancti Ioannis (quando si raccoglieva si era soliti legarla intorno alla vita).
ETIMOLOGIA
Il nome dell’iperico deriva dal greco hypo (sotto) erike (erica). Secondo Plinio il Giovane, il suo nome deriva dal greco “hyper – eikon”, in quanto può crescere anche sulle statue antiche: per questo motivo la tradizione popolare gli ha attribuito il potere di scacciare i fantasmi. Secondo le leggende contadine l’iperico sarebbe infatti legato a proprietà magiche e curative conosciute fin da tempi lontanissimi. Il nome botanico dell’iperico è composto di due parole, e la seconda, “Perforatum”, deriva dal latino e significa “perforato”, poiché le foglie viste controluce rivelano dei punti traslucidi, dando l’impressione che la foglia sia perforata.
FAMIGLIA E GENERE
Appartiene alla famiglia delle Clusiaceae (Guttiferae) e al genere Hypericum
PARTI USATE
Le parti usate in fitoterapia, sono le foglie e soprattutto le sommità fiorite.
TIPO DI PIANTA
Pianta erbacea o ad arbusti perenne sempreverde, anche sub-fruticosa con fogliame caduco o persistente con fiori gialli, bacche rosse o nere. Alta 30 – 80 cm e comunque non oltre 1 m, ha un fusto eretto, angoloso, percorso da due strisce longitudinali in rilievo. Le foglie sono piccole, oblunghe-ellittiche. Quando non è in fioritura tali foglioline viste in controluce appaiono bucherellate, da cui il nome perforatum. Trattasi in realtà di vescichette traslucide contenenti resine ed oli essenziali incolori. I fiori, a cinque petali di colore giallo-oro sono disposti a stella e raggiungono la fioritura verso fine giugno. Ai margini dei petali sono visibili dei punti neri per la presenza di strutture ghiandolari contenenti un succo oleoso di colore rosso-violaceo, chiamato volgarmente sangue di San Giovanni, che deve la sua colorazione all’ ipericina, sostanza di cui è particolarmente ricco. I frutti sono capsule ovali che a maturazione si aprono scoprendo i semi cilindrici di colore nero o bruno scuro.
HABITAT
Molto comune in Italia nei luoghi sassosi (campi secchi) muri, lungo le strade ed i fossi, nei boschi, ericeti, in pianura ed in collina. Naturalizzato negli U.S.A., in Europa, in Asia occidentale e in Nord Africa. Cresce nei luoghi asciutti, soleggiati ed erbosi, colline ed oliveti, ai margini delle strade di campagna ed oggi viene anche coltivata. Predilige l’esposizione al sole ma resiste anche in condizioni di ombra parziale. Predilige un clima abbastanza mite ma resiste anche alle basse temperature. Si adatta a quasi tutti i tipi di terreni, l’importante è che siano ben drenati. Non è una pianta soggetta a particolari malattie o parassiti.
COMPONENTI
Le sommità fiorite dell’iperico, dal sapore aromatico, amaro ed astringente, sono un concentrato di sostanze attive, tra cui l’ipericina e l’iperforina, che favoriscono una migliore qualità del sonno senza alterare la fase R.E.M. L’ipericina ha anche dimostrato di possedere promettenti proprietà antitumorali e ha la capacità di inibire la crescita di gliomi (tumori cerebrali), del cancro al polmone e del cancro della pelle in vitro (in laboratorio). Contiene inoltre bioflavonoidi come la quercetina e la quercitrina, che regolano il tono dell’umore contrastando ansia e angoscia, rilassando le tensioni e promuovendo una sensazione di benessere naturale. Biapigenina e amentoflavina agiscono direttamente sul sistema nervoso, legandosi ai recettori che inviano segnali di rilassamento al cervello. La biapigenina, in particolare, contrasta i sintomi nervosi come il bruxismo, i disturbi gastrici su base nervosa e la secchezza delle fauci, mentre l’amentoflavina è efficace in tutti i casi di infiammazioni gastriche e ulcere. I suoi principi attivi, inoltre, favoriscono la circolazione e migliorano l’attività del muscolo cardiaco. Le proprietà dipendono da un complesso di sostanze ciascuna delle quali presa separatamente non è sufficiente a motivare l’efficacia complessiva della pianta, l’efficacia si ha usando il fitocomplesso.
PROPRIETA’
 A seconda della tipologia d’uso ha proprietà diverse. Per via esterna l’iperico è un antisettico, antinfiammatorio e cicatrizzante. Per via orale è usato soprattutto come antidepressivo. A livello sistemico si usa per le proprietà rasserenanti, calmanti degli stati ansiosi e antidepressive. Quest’ultima attività è risultata essere, in numerosi studi, molto simile a quella dei trattamenti farmacologici tradizionali, manifestando un minor numero di effetti collaterali. Tra le molte proprietà dell’iperico oggi riconosciute c’è quella di essere un potente serotoninergico e quindi un antidepressivo naturale, indicato specificamente negli stati depressivi accompagnati da ansia a sfondo emotivo, con agitazione, attacchi di panico disturbi gastroenterici e difficoltà di addormentamento. Oltre ad aumentare i livelli di serotonina assunto come integratore l’iperico modula anche la secrezione di melatonina, cosa che lo rende utile in caso di insonnia. Sul piano fisico la medicina riconosce all’iperico proprietà immunostimolanti, antinfiammatorie, antibiotiche, antivirali, antimicotiche, antisettiche e antidolorifiche che lo rendono un ottimo rimedio in tutti i casi di distonie neurovegetative, gastriti, ulcere gastro-duodenali e nelle nevralgie croniche.
A seconda della tipologia d’uso ha proprietà diverse. Per via esterna l’iperico è un antisettico, antinfiammatorio e cicatrizzante. Per via orale è usato soprattutto come antidepressivo. A livello sistemico si usa per le proprietà rasserenanti, calmanti degli stati ansiosi e antidepressive. Quest’ultima attività è risultata essere, in numerosi studi, molto simile a quella dei trattamenti farmacologici tradizionali, manifestando un minor numero di effetti collaterali. Tra le molte proprietà dell’iperico oggi riconosciute c’è quella di essere un potente serotoninergico e quindi un antidepressivo naturale, indicato specificamente negli stati depressivi accompagnati da ansia a sfondo emotivo, con agitazione, attacchi di panico disturbi gastroenterici e difficoltà di addormentamento. Oltre ad aumentare i livelli di serotonina assunto come integratore l’iperico modula anche la secrezione di melatonina, cosa che lo rende utile in caso di insonnia. Sul piano fisico la medicina riconosce all’iperico proprietà immunostimolanti, antinfiammatorie, antibiotiche, antivirali, antimicotiche, antisettiche e antidolorifiche che lo rendono un ottimo rimedio in tutti i casi di distonie neurovegetative, gastriti, ulcere gastro-duodenali e nelle nevralgie croniche.
Trova inoltre applicazione nel trattamento delle palpitazioni, dei cambiamenti d’umore e di altri disturbi tipici della menopausa, del disturbo da deficit di attenzione/iperattività, del disturbo ossessivo-compulsivo, della sindrome affettiva stagionale. Infine, è stato sperimentato anche in caso di esaurimento, la sindrome da fatica cronica, l’emicrania e altre forme di mal di testa, i dolori muscolari e di origine nervosa, la sindrome del colon irritabile.
L’iperico viene utilizzato da lungo tempo per via topica per le sue proprietà antinfiammatorie cicatrizzanti e antisettiche. È utilizzato per trattare lividi e lesioni cutanee, infiammazioni e dolori muscolari, ustioni di primo grado, ferite, punture di insetto, emorroidi e dolore di origine nervosa.
Può essere utile sulle chiazze infiammate della psoriasi. Infine, sempre per uso esterno, può diventare ingrediente di un unguento per le emorroidi sanguinanti, a patto che sia associato ad altre erbe curative di questo specifico problema.
Le proprietà terapeutiche delle sommità fiorite dell’iperico sono dovute al fitocomplesso rappresentato essenzialmente da flavonoidi, come l´ipericina, la rutina e la quercetina, sostanze a spiccata azione antidepressiva e sedativa, che si ottengono dall’estratto secco o dalla tintura madre. L’ipericina, in particolare, inibisce due enzimi responsabili della disattivazione di vari mediatori del sistema nervoso centrale (serotonina, dopamina, noradrenalina) e aumenta la secrezione notturna di melatonina, aiutando contro l’insonnia. È, inoltre, in grado di accrescere i livelli serici di serotonina, similmente a certi farmaci antidepressivi, riequilibrando del tono dell’umore. Diversi esami hanno dimostrato che l´estratto di iperico, limita il riassorbimento di altri due neuro recettori denominati noradrenalina e dopamina che possiedono anch’essi un ruolo importante nella depressione, negli sbalzi di umore durante il periodo menopausa, nella depressione stagionale e nei periodi di esaurimento nervoso.
L’iperforina e le ipericine sono responsabili del colore rosso dell’olio di iperico, per questo la pianta è nota anche come “erba dell’olio rosso”.
Per avere effetti sulla depressione non deve essere usato sotto forma di estratto secco titolato in ipericina. Gli studi confermano l’improprietà dell’estratto secco perchè l’azione antidepressiva dell’iperico si esplica solo se c’è la presenza in forma proporzionale di ipericina e iperforina. Se uno manca, la funzione antidepressiva viene meno. In più l’estratto secco con evidenza eclatante di ipericina depaupera il resto del fitocomplesso che non si esprime adeguatamente. L’olio di iperico o la tintura alcolica (tintura madre) sono i preparati che meglio esaltano le potenzialità di questa pianta perchè l’ipericina e l’iperforina sono altamente liposolubili e alcool solubili (l’idrolito di iperico non ha quindi nessun effetto antidepressivo se non in quantità alte in cui possiamo trovare tracce di queste due componenti).
Secondo la Medicina Spagyrica l’Iperico è in grado di disgregare i calcoli renali, curare i catarri bronchiali sanguinolenti, espellere la bile gialla e giovare in caso di infiammazione del nervo sciatico. Il tropismo di quest’erba è rivolto a reni, pelle, articolazioni e cuore/emozioni.
 INDICAZIONI TERAPEUTICHE
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
L’iperico si assume per via orale. Le parti della pianta utilizzate per produrre i fitoterapici che lo contengono sono i fiori e le foglie. L’olio di iperico è, invece, pensato per l’uso topico. L’iperico si utilizza per via interna in compresse, capsule o tisane come ansiolitico moderato. Viene privilegiato per regolare il sonno e l’umore in occasione di disturbi legati alla stagionalità, all’età, a cambiamenti ormonali come la menopausa o a particolari momenti della vita. Per uso esterno in olio o pomate è apprezzato come disinfettante, antivirale (per esempio nell’herpes), antibatterico, antimicotico e cicatrizzante e riepitelizzante di ferite, ustioni e piaghe o anche in prodotti cosmetici doposole o per la couperose.
USO INTERNO
300-900 mg di estratto secco 1-2 compresse da 300 mg 1-3 volte al dì.
50 gocce di tintura madre con un po’ di acqua 1-3 volte al giorno per 2 mesi consecutivi. Interrompere un mese e, se necessario, ripetere il ciclo di trattamento.
INFUSO: 1 cucchiaio raso sommità fiorite di iperico, 1 tazza d’acqua. Si versa la miscela di foglie e fiori nell’acqua bollente e si spegne il fuoco. Si copre e si lascia in infusione per 5-6 min. Si filtra l’infuso e berlo al momento del bisogno in caso di infiammazioni osteoarticolari, infiammazioni urinarie e del colon.
OLEOLITO
 Con i fiori dell’iperico si prepara un olio dall’eccellente effetto antinfiammatorio, lenitivo e cicatrizzante, utile sia per contrastare i dolori reumatici, sciatica, artriti, che in caso di piccole ustioni, ferite, micosi, cicatrici, smagliature e psoriasi, contusioni, eritemi, ma anche contro le rughe.
Con i fiori dell’iperico si prepara un olio dall’eccellente effetto antinfiammatorio, lenitivo e cicatrizzante, utile sia per contrastare i dolori reumatici, sciatica, artriti, che in caso di piccole ustioni, ferite, micosi, cicatrici, smagliature e psoriasi, contusioni, eritemi, ma anche contro le rughe.
PROCEDIMENTO: Si riempie un barattolo di vetro (3/4) di fiori freschi di iperico, si aggiunge un olio vegetale (evo, di  mandorle, di sesamo, ecc. ) fino a 2 centimetri dal bordo. Si aggiunge un cucchiaino di liquore tipo grappa. Si chiude bene il barattolo e si lascia esposto alla luce solare, agitandolo una volta al giorno. Dopo circa 28 giorni, quando l’olio avrà assunto un colore rosso, si filtra l’oleolito e si travasa l’olio in una bottiglia di vetro scuro. L’oleolito si conserva al buio.
mandorle, di sesamo, ecc. ) fino a 2 centimetri dal bordo. Si aggiunge un cucchiaino di liquore tipo grappa. Si chiude bene il barattolo e si lascia esposto alla luce solare, agitandolo una volta al giorno. Dopo circa 28 giorni, quando l’olio avrà assunto un colore rosso, si filtra l’oleolito e si travasa l’olio in una bottiglia di vetro scuro. L’oleolito si conserva al buio.

PRECAUZIONI E CONTROINDICAZIONI
Parecchi studi farmacologici e clinici, effettuati sul vegetale, dimostrano che l’iperico è un vegetale sicuro, ma può presentare alcune controindicazioni come la sua azione fotosensibilizzante della cute particolarmente in soggetti con pelle capelli e occhi chiari. Può quindi dare reazioni come arrossamento bruciore e prurito sulle parti esposte ai raggi UV. Per questo, a scopo precauzionale, dopo l’eventuale assunzione, è sempre consigliabile evitare di esporsi al sole (o farlo solo con adeguata protezione), o di sottoporsi a trattamenti con le lampade abbronzanti.
Anche l’applicazione dell’olio sulla pelle, sempre per via della presenza di principi attivi fotosensibilizzanti, può determinare la comparsa, per reazione ai raggi solari, di antiestetiche macchie che possono poi impiegare tempo per scomparire: per questo va sempre evitato l’uso topico del prodotto prima dell’esposizione al sole.
Tra gli effetti avversi che si possono manifestare ce ne sono alcuni comuni agli antidepressivi, come astenia e agitazione, tachicardia, incremento della frequenza delle minzioni, affaticamento, secchezza della bocca, riduzione della libido, o eventuali reazioni allergiche.
L’iperico non va somministrato in gravidanza e allattamento e nei bambini d’età inferiore ai 12 anni. Se l’estratto è generalmente controindicato in età pediatrica e nell’adolescenza, lo stesso veto non riguarda l’olio di iperico utilizzato per applicazioni topiche.
TOSSICITA’
Per quanto riguarda la tossicità, l’iperico è decisamente più sicuro dell’aspirina. Molte persone muoiono ogni anno negli soli Stati Uniti a causa dell’aspirina, di solito in seguito ad emorragie interne. L’iperico, al confronto, non ha ancora registrato un solo decesso umano in 2.400 anni di note uso medicinale.
In realtà, l’unica tossicità fatale nota è stata rilevata dall’assunzione di iperico da parte di alcuni animali, come le pecore, che non muoiono tanto per l’ingestione di grandi quantità di iperico, quanto, piuttosto, per l’esposizione al sole successiva.
In uno studio su 3.250 pazienti trattati con iperico, solo il 2,4% ha manifestato effetti collaterali.
Gli effetti indesiderati rilevati tendevano ad essere di lievi entità: irritazioni gastrointestinali, reazioni allergiche, stanchezza, agitazione.
INTERAZIONI
Sembrerebbe che l’iperico interferisca con il metabolismo di numerosi farmaci potenziandone o annullandone l’effetto. È pertanto sconsigliato l’utilizzo contemporaneo ad altre terapie. Questo vale soprattutto in riferimento all’assunzione per via interna (quindi per bocca) degli estratti.
Questa pianta stimola alcuni enzimi che metabolizzano i farmaci per cui ne riduce il livello circolante. Studi clinici hanno dimostrato, per esempio, che l’assunzione di questa erba officinale riduce i livelli nel sangue di farmaci come la digossina (sostanza appartenente alla categoria dei glicosidi digitalici, usata come medicinale in presenza di alcuni problemi cardiaci) e può anche ridurre l’effetto dei farmaci ad azione anticoagulante.
Generalmente se ne sconsiglia l’uso durante il trattamento con molti farmaci come contraccettivi orali, antidepressivi, farmaci che aumentano la sensibilità alla luce, fitoterapici o supplementi a base di glicosidi cardiaci, con proprietà serotoninergiche.
SINERGIE
Ferite da rimarginare/Ustioni: Olio d’Iperico + Olio di Calendula oppure Unguento con oleolito di Iperico e di Elicriso oppure Olio di Iperico + gocce di olio essenziale di tea tree (100:1)
Depressione 1: Iperico TM + Avena Selvatica TM (½ per Kg di peso corporeo, 2 volte al giorno per una ventina di giorni)
Depressione 2: Iperico TM ½ goccia al mattino, a metà mattina Betula Verrucosa MG e la sera il Ficus carica MG (per i gemmoderivati si consiglia una goccia x Kg di peso). Nel caso di persona anziana a metà mattina daremo Sequoia Gigantea GM invece di Betula.
Infiammazione del colon: Nelle tisane per il colon si consiglia spesso l’aggiunta di iperico Es: Tisana delle 3 M: Melissa, Malva, Maggiorana + Iperico
TRADIZIONE POPOLARE
 Secondo la tradizione popolare i suoi fiori, raccolti nella notte del 24 giugno, periodo di massima fioritura – giorno di san Giovanni – avrebbero proprietà magiche e il potere di scacciare i “demoni del male” dal corpo e dallo spirito. Una credenza confermata dalla scienza, a giudicare dalle numerose virtù curative che la fitoterapia moderna attribuisce all’iperico È nota anche con il nome di erba di San Giovanni o “scacciadiavoli”, per le proprietà rasserenanti. Vuole la tradizione popolare, infatti, che le erbe raccolte in questa notte abbiano un potere particolare e tutte le loro proprietà siano esaltate alla massima potenza, viene ritenuta altamente ripugnante dagli spiriti maligni, contro i quali bastava un soffio per cacciarli. In passato i contadini lo coltivavano spesso vicino a casa o ne appendevano piccoli mazzi su porte e finestre, a mo’ di amuleti, e veniva collocato anche nelle stalle per proteggere il bestiame.
Secondo la tradizione popolare i suoi fiori, raccolti nella notte del 24 giugno, periodo di massima fioritura – giorno di san Giovanni – avrebbero proprietà magiche e il potere di scacciare i “demoni del male” dal corpo e dallo spirito. Una credenza confermata dalla scienza, a giudicare dalle numerose virtù curative che la fitoterapia moderna attribuisce all’iperico È nota anche con il nome di erba di San Giovanni o “scacciadiavoli”, per le proprietà rasserenanti. Vuole la tradizione popolare, infatti, che le erbe raccolte in questa notte abbiano un potere particolare e tutte le loro proprietà siano esaltate alla massima potenza, viene ritenuta altamente ripugnante dagli spiriti maligni, contro i quali bastava un soffio per cacciarli. In passato i contadini lo coltivavano spesso vicino a casa o ne appendevano piccoli mazzi su porte e finestre, a mo’ di amuleti, e veniva collocato anche nelle stalle per proteggere il bestiame.
Si racconta che alla vigilia dell’omonima festa (S. Giovanni), per proteggersi dai malefici delle streghe, fosse utile portare una piantina di iperico insieme alla ruta, l’artemisia e l’aglio.
In molti paesi europei nella notte di S. Giovanni c’era l’usanza di danzare attorno al fuoco, cingendosi il capo con le sue fronde; una volta spenti i fuochi, le gettavano sui tetti delle case, per preservarle dai fulmini.
Qualunque sia la ragione del suo nome, dal Medioevo si credeva che dormire con un rametto di Erba di San Giovanni sotto il cuscino la notte di S. Giovanni (la notte prima marea di San Giovanni), facesse apparire il Santo in sogno, per dare la sua benedizione, e per impedire a chi lo vedeva di morire durante l’anno successivo.
 Esistono diverse leggende che vedono protagonista l’Iperico, eccone alcune delle più note. La prima leggenda che riportiamo è quella secondo cui l’iperico deriverebbe dal sangue di Prometeo che venne punito da Zeus per aver donato il fuoco agli esseri umani, simbolo della luce della ragione. Un dono prezioso ma ambivalente perché se da un lato consente all’uomo di scaldarsi e progettare un focolare, lo rende anche cosciente della morte. Un’altra leggenda lega l’iperico alla figura di San Giovanni Battista, decapitato per volere di Salomè. Si narra che l’iperico fosse germogliato dalle gocce di sangue di Giovanni e viene ricordato, non a caso, come erba di San Giovanni. Questo legame secondo le leggende è confermato dal fatto che i petali, strofinati tra le dita, macchiano tutto di rosso, il colore del sangue versato dal Santo.
Esistono diverse leggende che vedono protagonista l’Iperico, eccone alcune delle più note. La prima leggenda che riportiamo è quella secondo cui l’iperico deriverebbe dal sangue di Prometeo che venne punito da Zeus per aver donato il fuoco agli esseri umani, simbolo della luce della ragione. Un dono prezioso ma ambivalente perché se da un lato consente all’uomo di scaldarsi e progettare un focolare, lo rende anche cosciente della morte. Un’altra leggenda lega l’iperico alla figura di San Giovanni Battista, decapitato per volere di Salomè. Si narra che l’iperico fosse germogliato dalle gocce di sangue di Giovanni e viene ricordato, non a caso, come erba di San Giovanni. Questo legame secondo le leggende è confermato dal fatto che i petali, strofinati tra le dita, macchiano tutto di rosso, il colore del sangue versato dal Santo.
Secondo un’altra tradizione il motivo per cui l’iperico viene raccolto il giorno di San Giovanni, 24 giugno, è invece da ricollegare alle streghe. In questa data le streghe si riunivano per festeggiare e le persone, sapendo che erano in giro, si infilavano negli abiti erbe di protezione, come l’iperico o l’aglio.
streghe. In questa data le streghe si riunivano per festeggiare e le persone, sapendo che erano in giro, si infilavano negli abiti erbe di protezione, come l’iperico o l’aglio.
Si narra anche che il diavolo cercasse di bucare le foglie di iperico per permettere ai suoi seguaci di infiltrarsi ma la pianta non gli concesse comunque il passaggio e i piccoli fori che si vedono sulle foglie di iperico ricordano questa antica battaglia.
Veniva anche utilizzato nei rituali di purificazione e per la preparazione dell’acqua di San Giovanni, si dice inoltre che indossarlo aiuti ad allontanare le malattie stagionali.
Qualche leggenda afferma che sia utile per propiziarsi l’amore e se raccolto il 21 giugno o di venerdì, diventa un amuleto contro la tristezza e le malattie mentali.
Posizionato sotto il cuscino di una donna nubile, si dice faccia sognare il futuro marito.